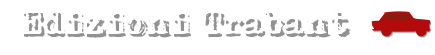Prefazione a
I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli – vol. II – Giuseppe Buttà
Il Museo del Risorgimento di Roma, più che un museo, pare a tratti un santuario religioso; d’altra parte, non a caso è situato in un edificio chiamato Altare della Patria. Buona parte dei cimeli esposti sono oggetti di scarso interesse storico, se non alla luce del concetto di reliquia: il visitatore potrà così vedere da vicino la sella di Garibaldi, i famosi occhialini di Cavour o il calco della testa di Mazzini preso sul letto di morte.
Camminare in quelle sale produce uno strano effetto, come un perenne riaffiorare di ricordi scolastici. Ogni bacheca riecheggia qualche episodio celebre della vasta mitologia fondativa della nazione, e persino delle canzoni vengono alla memoria: quando ci si trova davanti allo stivale originale indossato dall’Eroe dei Due Mondi in Aspromonte, con tanto di foro di proiettile, vien quasi da mettersi a fischiettare “Garibaldi fu ferito / fu ferito ad una gamba”.
Eppure, a un osservatore attento non potrà sfuggire un documento esposto nella prima sala, il quale costituisce una potenziale falla in questa agiografia nazionalista. È un ampio fazzoletto ricamato, del color dell’oro, con impresso un proclama a nome di “Ferdinando II – per la grazia di Dio – Re del Regno delle Due Sicilie”.
Ah, sì. La memoria scolastica si rimette in moto. Ferdinando, il Re Bomba, quello che distruggeva le città ribelli. Il Re che arrestava, incarcerava e – perché no? – torturava i mazziniani. Il monarca tanto crudele e oppressore da far sì che il suo regno fosse chiamato la negazione di Dio eretta a sistema di governo.
Il documento in questione – qualcuno l’avrà intuito – è la promulgazione della Costituzione delle Due Sicilie del 1848. Più precisamente, la data è l’11 febbraio ‘48. Quasi un mese prima dello Statuto Albertino. Quel fazzoletto ha impressa la prima costituzione concessa in Italia, e viene da Napoli, non da Torino.
Anche in questo caso, la memoria scolastica viene in aiuto a facilitare la comprensione di un evento così anomalo. Sì – è vero – la prima costituzione italiana è del regno duosiciliano, ma il Re Bomba la concesse perché costretto dai moti popolari. Tant’è vero che alla prima occasione utile, il 15 maggio successivo, ne approfittò per chiudere il Parlamento, fare arrestare i deputati e revocare le istituzioni democratiche. Fu un tradimento. Anzi, il tradimento, a confermare più che mai, se ancora ce ne fosse bisogno, la natura fedifraga e maligna del monarca.
Confrontando le fonti storiche, l’episodio dell’esperimento costituzionale del 1848 appare ben più complesso e soggetto a interpretazioni meno unilaterali di questa semplificazione da manuale scolastico. Celebre è l’aneddoto (a dire il vero di dubbia autenticità) secondo cui Ferdinando II si sarebbe così espresso nell’apporre la firma: «Sapìte che c’è? C’è che don Pio IX e il caro cugino Carlo Alberto hanno voluto gettarmi un bastone miezz’e ‘e cosce. Io allora butto a loro questa trave. Tié!». Ci sarebbe stato dunque, all’origine, un misto di guasconeria tipicamente italiana: maccherone, m’hai provocato? E io te magno. Altri storici dipingono un Ferdinando non del tutto convinto, ma in ogni caso intenzionato a venire incontro al desiderio della popolazione, o perlomeno a quello che, in un’epoca in cui le informazioni circolavano in modo piuttosto difficoltoso, lo avevano portato a credere fosse il desiderio della popolazione.
Resta un dato di fatto. Il 1848, e particolarmente la giornata del 15 maggio, rappresenta uno snodo fondamentale nella storia del meridione d’Italia. Quale ne sia l’interpretazione, quell’anno vide un tentativo di evoluzione democratica e liberale dell’istituzione monarchica borbonica; l’esperimento fallì miseramente, lasciando dietro di sé un solco irreparabile tra i liberali e la monarchia, ognuno addossando all’altro le responsabilità dell’insuccesso. I liberali avvertirono la sensazione di non poter più contare sulla collaborazione dei Borboni per la realizzazione del loro progetto e avviarono quel processo che avrebbe portato, da lì a 10 anni circa, all’appoggio all’unificazione italiana sotto la bandiera sabauda. Re Ferdinando, da parte sua, vide confermati i suoi peggiori pregiudizi nei confronti dei liberali, gli avvocaticchi, i pennaruli, come amava chiamarli, e passò dai buoni auspici dei primi anni di regno all’amarezza, disillusione e clima di sospetto dell’ultimo periodo. Riflettere su questo episodio è fondamentale, se si vuole comprendere la storia delle Due Sicilie e soprattutto la sua fine: senza la Costituzione del 1848 non si spiega nulla di ciò che accadde negli anni successivi, né le lettere di Lord Gladstone, né l’attentato di Agesilao Milano; né Carlo Pisacane, né Garibaldi.
E poi c’è lui, il Re Bomba.
Personaggio ingombrante, Ferdinando II. Anche nel fisico, era una figura che amava prendere per sé l’intera scena. Omaccione pingue e barbuto, in perenne ingrasso a causa del mai celato amore per la buona tavola; padre-padrone di una prole che arricchiva di anno in anno con un’instancabile attività riproduttiva. E altrettanto instancabile nel suo attivismo: è il re di Napoli che più di tutti ha viaggiato in lungo e in largo per il suo regno, a visitare i capoluoghi, nominare e destituire amministratori, incontrare le popolazioni, decretare opere pubbliche e riforme.
E invece questa figura, che i suoi partigiani di ieri e di oggi hanno sempre considerato alla stregua del buon padre della patria, bonario giudice e assennato amministratore, ha subìto alla metà del XIX secolo la condanna unanime dei liberali, in un crescendo che ne ha fatto via via l’incarnazione stessa del vizio e del male, fino ad accusarlo di qualunque tragedia, non escluse pestilenze e terremoti. Persino la morte della prima moglie, dovuta – si malignava – alle conseguenze di uno scherzo di cattivo gusto del marito.
Quale la realtà storica? Più d’uno studioso contemporaneo si è arrovellato nel tentativo di sciogliere questo nodo. Un compito così arduo che uno dei maggiori biografi dei Borboni, Harold Acton, parla di un carattere enigmatico del monarca e racconta la difficoltà che avevano i diplomatici stranieri, nei suoi primi anni di regno, a comprenderne le inclinazioni, temendo addirittura che nutrisse più di una nascosta simpatia per molte delle rivendicazioni liberali.
In effetti, una figura ben strana di tiranno: cede ripetutamente alle richieste di riforma delle élites borghesi; concede la Costituzione, si vede costretto a sospenderla ma si incaponisce per almeno un anno a provare e riprovare ad applicarla; dopo numerosi tentativi di ribellione non fa che perdonare i propri nemici elargendo grazie e riduzioni di pena. Come commentava con sarcasmo Carlo Alianello: se questo è un tiranno, cosa avrebbero detto i suoi detrattori se si fossero trovati tra le mani di un Hitler, di uno Stalin?
E qui torniamo a quanto detto precedentemente: è il 1848 napoletano il vero spartiacque, l’evento storico che segna definitivamente il destino del re davanti ai posteri e mette in moto quella campagna di diffamazione di cui resta traccia ancora oggi. È il vero momento in cui questo re cessa di essere il Padre dei Popoli e diventa per i posteri il Re Bomba.
Giuseppe Buttà, in questo secondo volume della sua storia dei Borboni di Napoli, introduce, dopo la breve parentesi di Francesco I, il regno di Ferdinando II e gran parte della narrazione ruota proprio intorno alle turbolenze del 1848-49. Una ricostruzione, inutile sottolinearlo, molto poco in linea con la vulgata corrente.
Superfluo raccontare ancora le vicende personali di don Buttà, che abbiamo già abbondantemente descritto nelle opere finora pubblicate. Quello che ci preme sottolineare ancora una volta è l’estrema utilità di queste cronache, allo scopo di arricchire la nostra conoscenza storica con un punto di vista opposto a quello più in voga. Il Ferdinando II tratteggiato dal sacerdote messinese è un paterno buon amministratore, colpevole tutt’al più di eccessi di indulgenza e inopportuna fiducia nel prossimo; attorno a lui, un nido di vipere in perenne cospirazione, decise a tutto pur di farlo cadere dal trono e ghermire il potere. Il tradimento del 1848 diventa così non il tradimento del re, ma quello del parlamento.
Come già fatto nel primo volume, incentrato per lo più sulla figura di Ferdinando IV, Giuseppe Buttà anche in questo caso ribalta le carte della vulgata corrente, sfida fior di storici e libellisti e si permette lo scandalo di criticare a ridicolizzare gli eroi del Risorgimento. E non lo fa – si badi bene – per tornaconto o chissà quale interesse, ma per sincero convincimento, con una passione che costituisce il vero asse portante dell’intera sua opera.
La stessa passionalità che, in alcuni momenti, lo porta a tradire persino le linee guida della sua scrittura. Per esempio, quando racconta la ribellione della Sicilia del 1848-49, il siciliano che è in lui riesce a emergere anche dal suo parteggiare per il governo di Napoli; e il fatto che il suo cuore batta per la monarchia borbonica non gli impedisce di fare uno strappo alla regola e, una volta tanto, spendere due parole buone nei confronti dei rivoluzionari:
Intanto, annunziare tre giorni prima la rivolta a’ governanti è un fatto unico nella storia; ciò dimostra qual popolo sia il siciliano, e quale la sua lealtà, il suo coraggio; le guerre si sono sempre intimate, (ad eccezione de’ governi rigeneratori), le rivoluzioni giammai. Nonpertanto vi son’oggi i redivivi allobrogi, atteggiati a civilizzatori d’Italia, che hanno avuto tanta impudenza di dar del barbaro a quel popolo eroico!
O quando nomina Silvio Spaventa nel capitolo IX. I due si erano conosciuti nel bagno penale di S.Stefano: Spaventa scontava l’ergastolo per attività cospirativa, Buttà era cappellano dell’istituto penitenziario. Si rividero nel 1861, nel turbine di avvenimenti successivi all’annessione piemontese: Spaventa, dopo aver avuto la pena condonata da Ferdinando II, era tornato in patria alla caduta del regno delle Due Sicilie, ottenendo subito un ruolo come capo della polizia di Napoli; Buttà, al contrario, era ricercato in quanto simpatizzante borbonico. Il sacerdote cercò di ottenere l’intercessione dell’ex galeotto, nel segno del trattamento umano che gli aveva riservato in più di un’occasione a S. Stefano; ma il rivoluzionario fece semplicemente finta di non riconoscerlo, lasciandolo al suo nuovo destino di perseguitato. Un episodio che a Buttà continuò a bruciare per anni, se è vero che già nel Viaggio dichiara di raccontarlo per togliersi un peso dallo stomaco; e anche nel presente volume, quando gli tocca nominare Silvio Spaventa, dà un’inaspettata impennata al suo consueto sarcasmo e spende per lui parole di una ferocia mai adoperata per alcuno, neanche per Cavour o Garibaldi, fino a chiamarlo superbo pezzente e mettere in ridicolo la sua vecchia condizione di ergastolano costretto a filare il lino in carcere per guadagnare due soldi.
Sono, questi, dei lapsus di umana debolezza che, a nostro avviso, aiutano capire perché sin dalle prime pagine questo autore ci è sembrato uno dei più vivaci e interessanti polemisti del XIX secolo, benché oggi quasi del tutto dimenticato. La sua scrittura impregnata di sarcasmo, l’irriverenza con cui dissacra i miti della Nazione e difende quelli che la storia ci ha tramandato come i cattivi di un film western, sono tutti elementi che ne rendono utile il recupero, un compito che ci siamo assunti sin dall’inizio della nostra attività editoriale.
E bisognerebbe adoperare cautela anche nel giudicare la presunta estrema faziosità di questo autore. Tra tutte, scegliamo una citazione:
«Ferdinando aveva ragione a ridere di quei ministri e a chiamarli responsabili di avere sfrenata la moltitudine. Il 15 maggio lo fecero i pazzi, non seppero impedirlo i savi, un furbo ne profittò. Mettiamoci una mano sul petto, e diciamo il vero: la colpa l’ebbero tutti ciascuno per la sua parte».
Attenzione, perché queste non sono le parole di Giuseppe Buttà, né di un fazioso apologeta dei Borboni, ma di Luigi Settembrini, uno dei cospiratori liberali condannati all’ergastolo sotto il regno del Re Bomba.
Meditate, gente, meditate.
Marcello Donativi